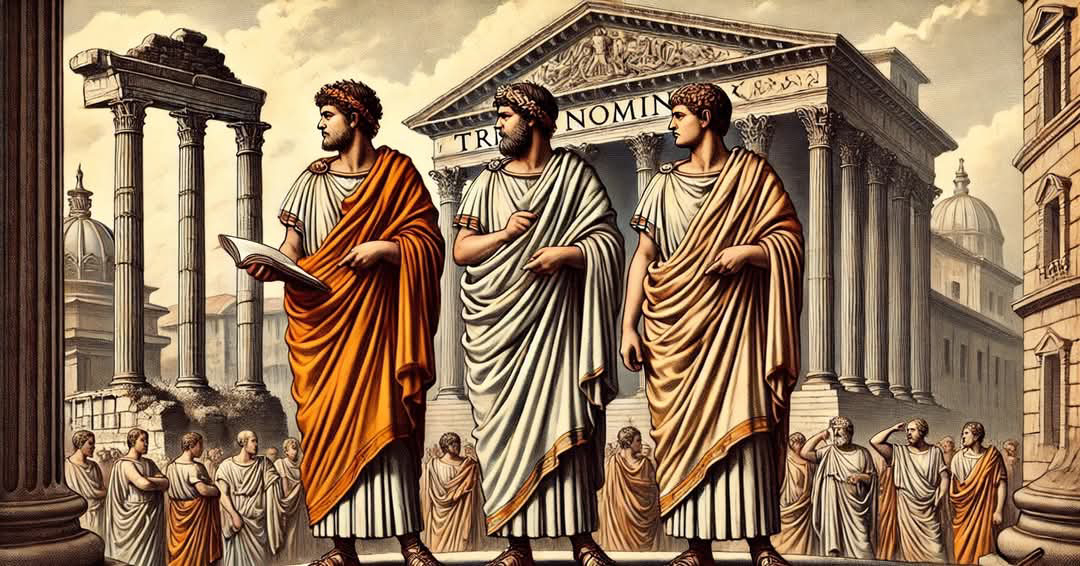Mamurra e Vitruvio non possono essere stati la stessa persona
Nato, secondo molti storici, a Formia, dopo aver prestato le sue conoscenze di costruttore di macchine da guerra prima a Cesare e poi ad Augusto, in tarda età scrive un trattato dove , in più parti manifesta il suo carattere, la sua personalità e descrive il suo aspetto fisico.
Questi sono , in proposito, i passaggi più importanti scritti nel suo Trattato dedicato a Augusto :
**********
" .......per la raccomandazione di tua sorella mi concedesti di scrivere questo trattato. E però , essendo io per quel beneficio tenuto ed obbligato di modo che io non aveva a temere, negli ultimi anni della vita mia, la povertà , io ho cominciato a scrivere queste cose...... "
"""" Ma a me , o imperatore, la natura non ha dato la grandezza del corpo, e la età mi ha deformata la faccia, e la infermità levate le forze; laddove, essendo io da così fatti presidj abbandonato, io spero per mezzo della scienza e degli scritti in qualche grado salire.
E però io grandissime ed infinite grazie rendo a' miei progenitori, i quali approvando la legge degli Ateniesi , mi hanno nelle arti ammaestrato, ed in quella specialmente che senza lettere e senza quella raccomunanza di tutte le dottrine che in giro si volge , non può per alcun modo essere commendata.
Grazie ai miei e alla dottrina dei miei maestri ho notevolmente arricchito il mio patrimonio di conoscenze occupandomi piacevolmente di argomenti letterari e tecnici .
Ma qualcuno forse , ritenendo queste cose di poco conto, è convinto che i veri saggi sian coloro che posseggono notevoli ricchezze, e così parecchi si son dati da fare per raggiungere questo obiettivo .
Io invece , o Cesare, non mi sono dedicato alla mia arte al fine di arricchire; sono piuttosto convinto che sia preferibile una onorata povertà ad una ricchezza disonorevole.
Ecco perché non ho grande fama.
Tuttavia spero che con la pubblicazione di questo trattato sarò noto anche ai posteri. """""
************
Bastano queste parole scritte dallo stesso Vitruvio, per capire che non può essere accomunato alla figura di Mamurra come alcuni vogliono convincerci.
È molto probabile che Marco Vitruvio Pollione e Lucio Vitruvio Mamurra siano appartenuti ad uno stesso ceppo familiare di liberti , ma di sicuro erano due persone con diverso carattere e diversa personalità.
Vitruvio povero, equilibrato e forse introverso.
Mamurra ricchissimo, spendaccione e bancarottiere, come ci fa sapere Catullo.
Mamurra era già noto per le sue abilità di ingegnere con Cesare in Gallia dove fu il protagonista del Ponte sul Reno costruito in dieci giorni e per i venti chilometri di fortificazioni attorno alla città di Alesia. Mamurra sapeva di non avere bisogno di scrivere alcun trattato per diventare noto ai posteri.
Con orgoglio, posso aggiungere un altro elemento che, più che probabile, è addirittura certo: Entrambi sono nati nella mia città di Formia.
Raffaele Capolino